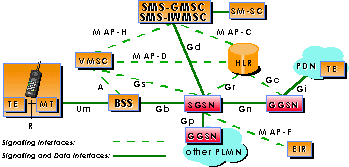Servizi Dati su mobile: prospettive di sviluppo ed evoluzione
E. Berruto, G. Castelli e P. Fasano
CSELT (Centro Studi E Laboratori Telecomunicazioni)
via G. Reiss Romoli, 274
10148 Torino (Italy)
 download PDF file (116 KB)
download PDF file (116 KB)
Premessa
I segnali evolutivi del mercato e gli svariati accordi e movimenti societari
di questi ultimi mesi, indicano chiaramente che una parte progressivamente
più significativa dell'innovazione nel settore dei servizi e dei
sistemi mobili sia dovuta all'evoluzione dei servizi dati su mobile.
Questa tendenza alla crescita dei servizi dati si presenta in termini
sia di differenziazione sia di incidenza quantitativa. In tal senso, i
dati su mobile rappresenteranno nel prossimo futuro uno dei settori ad
alto tasso di crescita e presumibilmente ad alta redditività per
il fornitore di servizi e per gli operatori del settore, anche se il volume
complessivo di questi servizi risulta oggi quantitativamente poco significativo
rispetto ai servizi voce. In questa situazione di mercato, la spinta all'innovazione
nasce soprattutto da una stretta sinergia tra:
-
le dimensioni e la diffusione raggiunte dai servizi mobili;
-
il parallelo sviluppo dei servizi e delle applicazioni dell'Information
Technology.
Questa sinergia è favorita dall'elevato tasso di aggiornamento del
parco terminali radiomobile e degli strumenti di sviluppo, che favoriscono
un rapido aggiornamento dei servizi e delle applicazioni.
Peraltro i requisiti e le caratteristiche tecniche e di mercato delle
applicazioni dati implicano radicali cambiamenti delle modalità
d'uso della risorsa radio (pacchetto) e dell'architettura di rete complessiva.
1. Evoluzione dei terminali e applicazioni
Il mercato radiomobile, in fase di evoluzione rapida e di competizione
particolarmente
aggressiva, richiede all'operatore una forte capacità strategica
di risposta in termini di innovazione e di cura del cliente. Di conseguenza
lo sviluppo di soluzioni applicative e sistemistiche per ambiente mobile
sarà sempre più focalizzato sull'attenzione alla possibilità
di personalizzazione e differenziazione in accordo ai requisiti di utente.
La crescita vorticosa del numero di clienti mobili è accompagnata
da un'elevatissima velocità di ricambio del parco terminali, creando
così l'opportunità di introdurre facilmente nuovi servizi
basati anche su caratteristiche innovative del terminale. Già attualmente
per quanto riguarda l'accesso ai servizi a valore aggiunto i terminali
si stanno differenziando come "voice centric"(smart phone) e "information
centric"(communicator). Tale trend sarà confermato anche per i terminali
di terza generazione, dove saranno presenti terminali tipicamente multimediali
per servizi video e di browsing evoluto.
La recente disponibilità di nuovi ambienti applicativi per la
fornitura di servizi a valore aggiunto di mobilità GSM, quali SIM
Application Toolkit, WAP (Wireless Application Protocol definito dal WAP
Forum, che comprende tutti i principali attori del mondo mobile e IT) e
MExE (Mobile Execution Environment, standard ETSI che recepisce WAP e Java
come punti cardine) prospetta un nuovo scenario rispetto al passato, in
termini di possibilità di sviluppo e supporto di applicazioni dati
o integrate dati e voce sia per il mercato orizzontale, che per le corporate,
oltre che come strumenti di realizzazione di soluzioni verticali.
I servizi WAP permettono, utilizzando il solo telefonino GSM, di accedere
in maniera interattiva ad informazioni ed applicazioni residenti su un
server web. Tale funzionalità è consentita dall'introduzione
di un micro-browser all'interno del telefonino, e permette di offrire servizi
applicativi a valore aggiunto. I servizi possono essere realizzati sia
per il mercato business che per quello consumer (servizi informativi come
notizie economiche o sportive e dispositivi come il mobile banking e il
mobile commerce) e si basano sui protocolli del mondo Internet, ottimizzati
per rispondere alle limitate capacità di banda e di visualizzazione
dei telefonini; la connessione avviene come trasmissione dati (in futuro
a pacchetto) verso la rete mobile, dove è collocato un gateway di
protocolli (WAP server) tra il mondo mobile GSM e quello di server applicativi
IP.

FIGURA 1 - Architettura Servizi VAS
I servizi basati su SIM Application Toolkit sono basati sulla capacità
crescente di elaborazione e memorizzazione offerta dalle carte SIM (ad
oggi 16kbyte, di cui 8 dedicati a 3-4 applicazioni disponibili per il cliente);
tali servizi sono uno strumento unico per la "customer retention" in quanto
la SIM è percepita dal cliente come elemento distintivo dell'operatore.
I servizi a valore aggiunto (home-banking, e-commerce, applicazioni location-based)
sono inoltre personalizzabili attraverso un meccanismo di caricamento "over
the air" e costituiscono un approccio complementare a WAP. La connessione
avviene tramite l'invio e la ricezione di short messages, guidati da menù,
verso la rete mobile, che li inoltra verso server applicativi.
Lo scenario è ancora più complesso considerando che parallelamente
alla disponibilità di questi ambienti applicativi sono resi disponibili
nuovi servizi portanti GSM di fase 2+ come GPRS (General Packet Radio Services).
Da qui deriva la necessità di definire un "mix tecnologico" per
l'introduzione di ogni nuovo servizio considerando le diverse alternative
di terminali, servizi portanti infrastrutture a supporto (SIM Application
Toolkit, WAP) e evoluzioni verso UMTS.
Per quanto riguarda le soluzioni applicative rese disponibili dalla
soluzione di rete mobile di terza generazione (UMTS) i principali trend
saranno guidati dalla nascita di terminali evoluti (dotati ad esempio di
display a colori ad alta definizione o add-on di tipo "paper-like" display,
o di telecamera integrata) e dalla disponibilità di accesso a larga
banda e a pacchetto. Si pensa inoltre che la caratterizzazione dell'UMTS
varierà a seconda dei paesi, permettendo anche una forte estensione
della capacità di trasmissioni vocali (come ad esempio per il Giappone)
o distinguendosi per l'uso di servizi multimediali ad alto bit-rate (in
Europa ed in particolare in Italia) e mantenendo sostanzialmente la trasmissione
voce su GSM. I settori applicativi trainanti per le evoluzioni su UMTS
saranno:
-
applicativi per la comunicazione interpersonale (audio e videotelefonia);
-
applicativi di messaggistica (Unified messagging, Video/Voice mail, Chat,
...);
-
information delivery (Servizi informativi, Servizi al cittadino, Teleformazione,
...);
-
applicativi di localizzazione evoluta (Navigazione personale, Car navigation,
...);
-
servizi corporate (Workflow management, Mobilità indoor, Total mobility
systems);
-
servizi di massa (Banking, m-commerce, monitoraggio, ticketing, ecc.).
Lo sviluppo di questi settori applicativi si avvale di piattaforme di supporto
che mettono a disposizione elementi di base, funzionalmente in rete, che
sostanzialmente sono raggruppabili secondo tre categorie:
-
piattaforme con tool-kit (tool di conversione di media, riconoscimento
vocale, analisi traffico e charging);
-
piattaforme con server di base (server per la certificazione e autenticazione,
profili d'utente, localizzazione, e m-commerce);
-
piattaforma intranet/internet (WAP, ...).
2. Evoluzione dei servizi dati nel GSM
L'evoluzione dei servizi di trasmissione dati definiti per la Fase 2+ dello
standard GSM è guidata da due obiettivi principali: il primo è
il superamento dell'attuale limite di velocità fissato a 9.6 kbit/s,
il secondo consiste nell'introduzione della modalità di trasmissione
a pacchetto anche sull'interfaccia radio.
Le soluzioni dati attualmente disponibili sul sistema GSM sono:
-
il servizio dati a circuito a 9.6 kbit/s (Circuit Switched Data-CSD).
La chiamata dati qui impiega un singolo canale di traffico e viene attivata
secondo le stesse procedure del servizio voce;
-
il servizio Short Message Service. Utilizza i canali di segnalazione
comuni o associati alla chiamata con modalità del tipo a pacchetto
per trasmettere messaggi di lunghezza fino a 140 bytes.
La soluzione High Speed Circuit Switched Data (HSCSD) [1] rende
disponibili, alla singola chiamata, multipli della capacità del
canale elementare (9.6 kbit/s o 14.4 kbit/s in funzione del tipo di codifica).
In tal senso rappresenta l'estensione naturale del servizio dati "monocanale"
oggi disponibile. La soluzione è relativamente semplice e può
essere introdotta in rete con modifiche lievi (capacità di controllo
multicanale, funzioni di adattamento).
Se le modifiche si limitano al livello di rete, mantenendo nel terminale
un unico transceiver, le configurazioni di servizio della singola
chiamata sono soltanto di due tipi:
-
due canali nei due sensi di trasmissione;
-
un canale nel senso mobile-stazione radio, quattro canali in senso opposto.
Soluzioni di terminale (e di rete) più evolute possono raggiungere
capacità trasmissive fino a 4 o 8 volte la capacità del canale
elementare.

FIGURA 2 - Architettura della soluzione HSCSD
La soluzione HSCSD impegna le risorse radio secondo la modalità
a circuito. Risulta quindi adatta a supportare servizi a bit rate
costante,
con requisiti di ritardo relativamente stringenti e requisiti di capacità
elevata. Per questo motivo presenta notevoli limiti di flessibilità
nell'uso delle risorse radio.
La soluzione General Packet Radio Service (GPRS) [2] utilizza
i canali radio secondo schemi a pacchetto (con prenotazione). Utilizza
le risorse radio in modo flessibile e può adattarsi a svariate esigenze
di servizio. Sono possibili due schemi di utilizzazione delle risorse di
cella: con risorse (canali) dedicate o con risorse attivate su richiesta.
La scelta tra le due opzioni potrà essere effettuata sulla base
delle esigenze locali del traffico dati e delle politiche tariffarie adottate.
Per ogni canale di traffico assegnato al servizio GPRS saranno disponibili,
in funzione della codifica adottata, capacità da 9 a 21.4 kbit/s.
Il servizio GPRS consente un utilizzo efficiente delle risorse di rete
per quelle applicazioni che richiedono trasferimento dati a pacchetto le
cui caratteristiche di traffico sono almeno una delle seguenti:
-
transazioni in cui il tempo che intercorre tra due trasmissioni è
notevolmente superiore al ritardo di trasmissione;
-
trasmissioni frequenti di piccole quantità di dati;
-
trasmissioni occasionali di grandi volumi di dati.
Il sistema GPRS impone di introdurre in rete nuovi apparati (nodo a pacchetto
e gateway verso le reti dati) che in pratica costituiscono una rete
parallela a quella per servizi voce (di questa condivide la parte di accesso
radio e le risorse di localizzazione). La necessità di introdurre
queste nuove entità sembrerebbe rappresentare un vincolo non indifferente
o un elemento di debolezza rispetto alla soluzione HSCSD.
Tuttavia la configurazione GPRS presenta due tipi di vantaggio:
-
flessibilità di uso delle risorse radio e adattabilità in
funzione del mix di servizi e dei relativi requisiti di prestazione;
-
compatibilità con le soluzioni più avanzate di terza generazione.
-
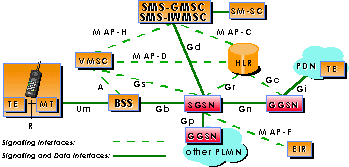
FIGURA 3 - Architettura della soluzione GPRS
La prima caratteristica deriva dalla flessibilità di impiego
della commutazione di pacchetto per servizi dati con forti livelli di variabilità
della capacità richiesta; la seconda dal fatto che il GPRS già
utilizza per il trasporto protocolli del tipo IP. Quest'ultimo protocollo
sarà probabilmente adottato nel sistema UMTS, sicuramente almeno
per il traffico dati.
3. Servizi IP con accessi mobili
L'offerta di servizi basati sull'Internet Protocol (IP), come ad esempio
l'accesso ad Internet o l'accesso alle Intranet aziendali, attraverso i
sistemi mobili tradizionali risente delle limitazioni intrinseche a questi
sistemi nel trattamento dei dati. Tra le principali limitazioni si ricordano:
la banda limitata (9.6 kbit/s per il GSM), i tempi di set-up delle
connessioni, l'inefficace uso delle risorse radio e la tariffazione a tempo.
Le diverse evoluzioni in atto o previste per il sistema GSM vanno nella
direzione di superare queste limitazioni. Come indicato in precedenza,
l'avvento del sistema GPRS rappresenterà un punto di svolta estremamente
significativo, perché comporterà l'introduzione di caratteristiche
innovative quali la commutazione a pacchetto ed un uso più consono
ai dati dell'interfaccia radio. La rete GPRS avrà inoltre la capacità
di interfacciarsi in modo nativo verso le tradizionali reti IP (Internet
Service Provider -ISP-, Internet, Corporate networks) attraverso apparati
di gateway che nei confronti del mondo IP risultano a tutti gli
effetti dei router.
Queste evoluzioni sono foriere di interessanti opportunità per
gli operatori mobili: espandendosi ben oltre i confini del loro tradizionale
mercato della fonia, essi possono aspirare a diventare non solo Access
Provider verso le reti IP possedute da terze parti ma anche ISP essi stessi.
L'insieme dei vantaggi apportati dal GPRS ha un suo rovescio della
medaglia nella complessità architetturale del sistema, che relativamente
all'offerta di servizi IP non è immune da alcune inefficienze. I
motivi di questa situazione sono da ricercarsi nell'origine della specifica
del sistema GPRS, che iniziata alcuni anni fa si era posta l'obiettivo
di offrire agli utenti dati servizi sia IP sia X.25. L'interesse verso
i servizi X.25 è successivamente diminuito, ma il sistema GPRS che
è stato standardizzato resta in grado di supportare entrambi i servizi,
a scapito di possibili ottimizzazioni nelle soluzioni tecniche per offrire
il solo servizio IP.
Contemporaneamente all'evoluzione dei sistemi mobili, anche all'interno
delle reti IP sono sorti e stati affrontati problemi per il supporto della
mobilità. Le esigenze di poter accedere alla rete Internet indipendentemente
dal punto (e dalla tecnologia di rete sottostante) di collegamento o quella
di poter accedere da remoto ai servizi di rete Intranet sono state tra
le più forti emerse nel mondo IP negli ultimi anni. Tali esigenze
hanno portato allo studio ed allo sviluppo di componenti di servizio utili
allo scopo: meccanismi di autenticazione ed accounting,
tunneling,
tecniche per aumentare la sicurezza delle comunicazioni, strumenti per
permettere il roaming tra ISP diversi. Inoltre l'IETF (Internet
Engineering Task Force) ha sviluppato una tecnica di routing denominata
"Mobile IP" [3], che è capace di superare le tradizionali limitazioni
del routing IP per supportare la mobilità di terminali tra
sottoreti (macro-mobilità). Questa tecnica, che pure presenta molte
somiglianze con le tecniche di gestione di mobilità proprie del
sistema GSM, sfrutta i meccanismi propri dell'Internet Protocol e risulta
ottimale per l'offerta di servizi di mobilità in reti IP.
Il modello "Mobile IP", nei suoi aspetti di base, ha oggi raggiunto
un buon livello di maturità ed è sostanzialmente pronto per
essere utilizzato all'interno delle reti IP. In una prospettiva più
evolutiva sono recentemente comparse le prime proposte di estensioni di
questo modello per gestire la micro-mobilità (ad esempio al livello
della cella radio) che prefigurano nuovi scenari in cui il controllo della
mobilità viene effettuato completamente con tecniche nate nel mondo
IP.
A partire dalle evoluzioni in atto nel mondo IP, i tradizionali ISP
potrebbero evolvere per offrire servizi di mobilità, così
come i tradizionali operatori mobili stanno avanzando verso il mercato
dei servizi IP. Nell'evoluzione di più lungo termine è pertanto
ipotizzabile una convergenza di interessi che potrebbe portare ad un nuovo,
più ampio mercato per i servizi IP mobili, in cui competeranno attori
con diverse provenienze.
Dal punto di vista tecnologico, le parallele evoluzioni dei sistemi
mobili e delle reti IP portano ad interessanti possibilità di nuove
soluzioni, che traggono valore dall'integrazione di tecniche e modelli
nati in contesti diversi. Per questi motivi, nello sviluppo dei sistemi
mobili di terza generazione si sta iniziando a guardare con estremo interesse
alle proposte che derivano dal mondo IP.
4. Il sistema UMTS
Per quanto riguarda le prospettive di medio termine, il sistema mobile
di terza generazione UMTS [4] è di fatto progettato per rispondere
al presunto impatto dei servizi dati su mobile. Le configurazioni di integrazione,
la banda assegnata e le capacità minime sono state decise a livello
europeo e si fanno carico di fattori quali:
-
l'universalità dei servizi forniti, perseguita soprattutto attraverso
l'interazione diretta o indiretta col mondo Internet;
-
i requisiti di trasporto (144 kbit/s, 386 kbit/s e 2 Mbit/s a seconda dell'ambiente
di servizio e delle caratteristiche di mobilità);
-
le esigenze di flessibilità, raggiunte attraverso le due modalità
di accesso radio, l'uso diffuso di schemi a variable bit rate e
la possibilità di controllare significativi livelli di asimmetria
di servizio: differenza di capacità tra up e down link.
Mentre l'esigenza di universalità del servizio poggia sulle funzioni
di rete, sui livelli di integrazione (ad esempio con Internet) e sullo
sviluppo di funzioni intelligenti, i requisiti di trasporto e flessibilità
sono coperti in buona misura dalla modalità di accesso e di uso
della risorsa radio scelta per i sistemi di terza generazione.
Rispetto ai sistemi come il GSM, su questo piano vale un cambio di
paradigma che è particolarmente significativo proprio per la varietà
del traffico dati (classi di servizio) e per le sue caratteristiche di
dinamicità in termini di bit rate.
L'accesso W-CDMA accetta per sua natura una vasta gamma di bit rate
sullo stesso (unico) canale radio usato dalle stazioni mobili. Addirittura,
la cadenza di bit può essere variata lungo la stessa connessione
se la sorgente lo richiede. Nei sistemi TDMA, la scalabilità della
capacità di trasporto è più direttamente connessa
all'uso multiplo dei singoli bearer (time slot) e quindi
risulta meno flessibile.
La modalità d'uso della risorsa radio va inoltre vista per il
CDMA in un nuovo contesto operativo che evita i piani di frequenza e può
essere definito "guidato dall'interferenza" nel senso che le scelte di
allocazione della risorsa ad una connessione devono direttamente fare i
conti col livello di interferenza presente in quel momento. Tale livello
non è infatti garantito a priori, come accade nei sistemi TDMA,
dove il piano di allocazione frequenziale (deciso in fase di pianificazione)
recupera in sé la necessaria protezione interferenziale.
Soluzioni basate su ATM nella parte di accesso stanno guadagnando credito
grazie alle caratteristiche di potenziale affermazione in numerosi contesti
(Core Networks delle reti fisse, Backbone per reti dati)
e a specifiche caratteristiche che le rendono particolarmente adatte per
la rete di accesso UMTS.
Come già detto, i servizi voce rimarranno essenziali anche nell'UMTS.
I blocchi radio ricevuti dalla stazione base contengono circa 100 bit per
ogni cadenza di trama di 10 ms. La cella ATM per contro, contiene circa
500 bit di informazione. Quindi, l'utilizzo di ATM nella parte fissa della
rete d'accesso richiede, per il servizio voce, di limitare le latenze trasmissive,
garantendo al contempo una buona efficienza della cella ATM. Ciò
può essere ottenuto con il livello di adattamento AAL2 che consente
di multiplare più flussi nella stessa cella ATM.
I blocchi radio relativi ai servizi dati, hanno le stesse caratteristiche
dei blocchi vocali. In questo caso l'impiego della tecnica ATM nella parte
fissa della rete d'accesso si giustifica perché realizza la stessa
flessibilità di uso delle risorse garantita dal variable bit
rate
sull'interfaccia radio.
Infine, la scelta dell'ATM nella rete di accesso ne favorisce l'estensione
anche alla rete core dell'UMTS, soprattutto in funzione della finalità
di evitare la doppia transcodifica (attualmente presente nel GSM) nel caso
di traffico voce mobile-mobile.
Nella Core Network (la parte di commutazione della rete UMTS)
si prospetta per i servizi dati una diretta integrazione con la rete IP,
con le sue possibilità di networking e con la varietà
di servizi e applicazioni già sviluppati per la rete fissa.
Al di sopra del controllore delle stazioni radio base, la dipendenza
dalla caratteristiche della parte radio è completamente risolta.
Può nascere quindi una diversificazione nel trattamento del traffico
voce rispetto al traffico dati.
Gli studi riguardanti il segmento di core network del sistema
UMTS sono ancora in corso. Una prima possibilità prevede il mantenimento
della separazione fra voce e dati, dove questi ultimi utilizzano un backbone
GPRS evoluto. Una seconda alternativa propone una integrazione fra i due
tipi di traffico, che può essere realizzata su una piattaforma orientata
al circuito e basata su ATM o su una piattaforma orientata al pacchetto
e quindi basata su IP. Questa ultima opzione appare particolarmente interessante,
in quanto si inserisce a pieno titolo nel filone dell'integrazione fra
telecomunicazioni mobili ed Information Technology.
5. Conclusioni
Nei prossimi anni le telecomunicazioni mobili entreranno in una fase di
rilevante innovazione. I nuovi requisiti di servizio, soprattutto nel settore
dei dati, di capacità e flessibilità delle reti coinvolte
e le nuove esigenze di banda radio costituiscono gli elementi su cui si
verificheranno i principali eventi di svolta. Le scelte di sviluppo per
l'operatore derivano in particolare da alcuni fattori gestionali e di mercato
che già oggi condizionano lo sviluppo delle comunicazioni mobili:
-
la necessità di migliorare i processi di definizione e di sviluppo
dei servizi innovativi e di valutarli secondo criteri di complessità
e redditività, anche in relazione alle forti dinamiche del mercato;
-
l'evoluzione dei servizi dati, caratterizzata da un significativo allargamento
delle capacità di trasmissione richieste e da una forte differenziazione
delle applicazioni offerte;
-
la necessità di disporre di nuove capacità per l'utilizzo
e il controllo della risorsa radio in funzione della rapida evoluzione
della domanda e della presumibile frammentazione dell'offerta.
Questi elementi devono essere considerati anche nell'ottica di medio termine,
allo scopo di predisporre strumenti e capacità di controllo in relazione
alle soluzioni che verranno via via prospettate. Gli operatori di reti
e servizi cellulari e in certa misura quelli di rete fissa, dovranno infatti
affrontare problemi gestionali e di servizio in situazioni significativamente
diverse
rispetto a quelle attuali.
Bibliografia
[1] "High Speed Circuit Switched Data (HSCSD); Stage 1", ETSI GTS GSM 02.34
v5.2.0
[2] "General Packet Radio Service (GPRS); Service description; Stage
1", ETSI GTS GSM 02.60 v6.1.0
[3] C. Perkins, "IP Mobility Support", IETF, RFC2002, 1996
[4] Special Issue, "Third Generation Mobile Systems in Europe", IEEE
Personal Communications Magazine, vol. 5, n. 2, Aprile 1998